

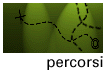



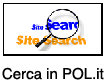
 |
 |
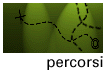 |
 |
 |
 |
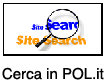 |
|
Attenzione: questo Ë un vecchio file, che conteneva la quarta e ultima parte dell'articolo di Cremerius che era diviso in quattro parti, successivamente accorpate alla prima. Torna quindi all'indirizzo: http://www.pol-it.org//ital/riviste/psicouman/cremeriuspsi.htm
Psicoterapia e Scienze Umane, 1999, XXXIII, 4: 5-43
Johannes Cremerius
NOTE
1. Qui si rinnova la tradizione dell'Antico Testamento: “Siate temperanti - createvi molti seguaci e costruite una torre intorno alla teoria” (sentenze del padre). Echeggia anche nella storia della origine del Comitato. Freud si circondò in esso di sette allievi e si legò a loro col dono di un anello con una antica gemma che egli stesso portò. La sua pietra mostrava la testa di Giove. In Matteo (9.9, 10.3) si dice che Gesù scelse i suoi seguaci di Cafarnao nega cerchia dei dodici (apostoli).
2. Erikson ironizzava su ciò dicendo che la psicoanalisi era scaturita dalla testa di Freud come “Atena dalla testa di Zeus” (Erikson, 1957, pag. 80).
3. Il valore della selezione corrisponde alla legge del caso: 50% di prognosi esatte, 50% di prognosi errate, si conta il caIo dei candidati nella analisi didattica.
4. Nel 1918 Nunberg propose al Congresso di Budapest, incitato a ciò da Freud, che ogni analista dovesse compiere una propria analisi personale. Soltanto nel 1926 la proposta fu accolta, contro certe opposizioni, al congresso di Homburg. Da allora esiste il concetto di “analisi didattica”.
5. Balint ricapitolò la situazione nel modo seguente: “Da parte dei comitati d'insegnamento e degli analisti didatti notiamo segretezza del loro sapere esoterico, pronunciamenti dogmatici di fronte alle nostre richieste e tecniche autoritarie. Da parte dei candidati (...) notiamo docile accettazione di leggende esoteriche, sottomissione a un trattamento dogmatico e autoritario senza molte proteste. Sappiamo quale obiettivo hanno tutti i riti di iniziazione: debbono costringere il novizio a identificarsi col clan. Noi sappiamo invece che ciò che dobbiamo proporci coi nostri candidati è che sviluppino un Io critico e forte. In contrasto con questo obiettivo consapevole, il nostro peculiare comportamento come didatti produce caratteri ed il nostro sistema di formazione va a finire che immancabilmente porta ad un indebolimento di questa funzione dell'Io dei nostri candidati” (Balint, 1947, pag. 317).
6. I movimenti di ribellione e di scissione provengono da Jung, Adler, Steckel, Max Graf, Otto Grass, fino a Melanie Klein, Horney, Rado, Sullivan, Fromm, Kohut. Il carattere tipico da guerra di religione col quale essi talvolta furono conclusi dimostra che qui si trattava di vera fede e non di scienza. Penso in particolare alla battaglia tra Anna Freud e Melanie Klein, nella quale ad ognuna delle due combattenti era permesso ogni mezzo (Steiner, 1985).
7. Come esempi dell'odio dell'analizzando verso il suo didatta faccio riferimento ad Ernst Jones, che si comportò per tutta la vita in modo pregiudizievole verso il suo didatta Ferenczi: “un piccolo e vile autore di depliants” (Balint, 1958), che alla fine della sua vita sarebbe diventato psicotico Jones, 1957, pag. 214). All'opposto didatti perseguirono i loro analizzandi. Questa sorte toccò a Margaret Mahler. La sua analista didatta, Helene Deutsch, interruppe la sua analisi e comunicò al comitato di didattica che era inanalizzabile (Stepansky, 1989, pag. 88). A quest'area appartiene anche il tragico distanziamento di Freud dal suo analizzando Ferenzci. Egli permise che la pubblicazione dell'intervento di Ferenczi al congresso di Wiesbaden, che egli non potè accettare, fosse per anni impedita.
8. In Germania, dove l'abilitazione alla psicoterapia della cassa mutua è possibile solo su licenza di un istituto di formazione accettato dalla confederazione dei medici mutualisti (intuisco come siano difficili altre vie d'accesso), il fallimento della formazione significa il rifiuto dell'abilitazione.
9. La segretezza si trasforma facilmente in censura. Esemplare a questo proposito è la prima edizione delle lettere a Fliess. I curatori apportarono tagli, senza farne cenno, raccolsero solo 168 delle 284 lettere, senza indicare il criterio secondo cui avevano effettuato la selezione.
10. L'Associazione psicoanalitica americana (Apa) accettò “laici” alla formazione, solo dopo che fu condannata a questo, dopo un processo perso in difesa del monopolio dei medici. L'Ipa diede il suo appoggio all'analisi dei laici, quando la Kbv la dichiarò non compatibile con le direttive della psicoterapia.
11. Come divenga ristretto il campo dell'esperienza dell'analista, lo dimostra il fatto che molti analisti cominciano l'analisi solo se il paziente può dimostrare di possedere i mezzi per pagare l'intera analisi attraverso una documentazione bancaria (Kubie, 1956; Menninger, 1958). Analisti svizzeri di scuola kleiniana si fanno pagare (ancor oggi) in anticipo di volta in volta per l'anno seguente.
12. Nella Repubblica federale tedesca, dove quasi tutti i soci della Dpv prendono parte alla psicoterapia mutualistica, cioè debbono osservare le sue regole (a bassa frequenza, limitata nel tempo, procedura peritale, criteri di redditività e di convenienza ecc.), la tecnica psicoanalitica classica, così come ancora viene rappresentata, è stata già trasformata in una psicoterapia analitica come ogni altra e non è più riconosciuta dall'Ipa come una tecnica psicoanalitica (Cremerius, 1990a, 1992a).
13. È meritevole di considerazione il fatto che, in sincronia con questa “maternità collettiva”, cresca la pratica assistenziale del “sostenere” (Winnicott), la raccomandazione che l'analista deve essere come una madre per il bene del paziente. È sorprendente come questa nuova tecnica sia vista solo come una variante della tecnica psicoanalitica e non invece in rapporto al citato mutamento sociale. Di nuovo si rende visibile lo scotoma sociale della psicoanalisi istituzionalizzata.
14. Qui un esempio: una commissione dell'Ipa doveva chiarire il rapporto tra psicoanalisi e psicoterapia. Non le riuscì, nonostante uno sforzo durato decenni (dal 1949 al 1980), di definire consensualmente la differenza. Wallerstein nel 1980 dichiara a questo proposito:
15. Già ora si intravede la conseguenza del nuovo ordinamento specialistico per il futuro dell'istituto della Dpv; il numero dei candidati è drasticamente calato. In uno dei 14 istituti è già sceso a un solo partecipante alla formazione. 16. Thomä e Kächele condividono questo punto di vista: “la critica portata avanti da Schultz-Hencke nel primo congresso tenuto dall'Ipa dopo la guerra a Zurigo sulla teoria della libido ed alla metapsicologia non solleverebbe oggi più alcuna sensazione e sarebbe condivisa da molti analisti ”(Thomä/Kächele, vol. 1, pag. 12, pag. 6 nella ed. italiana). 17. L'ottantenne Therese Benedek rispose a Basch alla domanda di quanti pazienti avesse trattato nella sua vita professionale in senso strettamente psicoanalitico: forse tre o quattro. Basch aggiunge che ciò coincide con la propria esperienza e con quella di molti suoi colleghi (Basch, 1991). Winnicott constata che l'era di questa psicoanalisi (il metodo standard) sta giungendo inesorabilmente alla fine. E “solo con una insignificante percentuale dei molti pazienti che vengono da me, è iniziata un'analisi standard” (Winnicott, 1986, pag. 101). Come di fatto si fosse allontanato dal metodo standard, ce lo mostra l'analisi condotta con Margaret Little tra il 1957 e il 1967 (Little, 1991). 18. Nello stesso periodo in cui Freud trattava Marie Bonaparte, Glover condusse il suo studio sui “Fondamenti teorici e clinici della terapia psicoanalitica”. La sua conclusione: non si può parlare né in termini contenutistici, né formali di una tecnica uniforme, di un “nocciolo di identità” (Glover, 1937). 19. [N.d.T] Al tempo in cui è stato scritto il presente articolo. Come noto, Sandler è recentemente scomparso.
Riassunto. L'articolo, comparso in Germania nel 1995 in un'antologia di scritti sul futuro della psicoanalisi curata da Cremerius e col contributo di alcuni autori di lingua tedesca, rappresenta il punto più alto della critica radicale condotta dall'autore sulla psicoanalisi istituzionalizzata. Cremerius ripercorre la storia del movimento psicoanalitico dalle origini; ne esamina gli snodi più salienti, ne analizza i punti critici e le contraddizioni. Viene evidenziato come le scelte compiute dalla istituzione siano state il più delle volte ispirate da motivazioni “politiche” tese alla propria autoconservazione. Ciò si è verificato con importanti conseguenze sul piano della teoria, della tecnica e della didattica. Ci si è allontanati dai criteri universalmente riconosciuti come fondanti delle scienze umane e della moderna ricerca scientifica, con una progressiva emarginazione da queste. È inoltre andato perduto il fondamentale contributo che la psicoanalisi ha fornito nei suoi primi anni alla critica della società e della cultura. Cremerius termina l'articolo formulando la propria sentenza/proposta: che cioè la psicoanalisi trovi la forza di rigenerarsi dal proprio interno, superando il vizio burocratico, che abbia il coraggio di rimettersi in discussione dalle radici, collegandosi organicamente e senza pregiudizi alle altre scienze, ritrovando così anche il proprio ruolo di teoria critica.
Summary. The article, appeared in 1995 in Germany as part of an anthology on the future of psychoanalysis by Cremerius with the contribute of other Ger man authors, represents the highest point of radical criticism developed by the author on institutional psychoanalysis. The author recovers the history of psy choanalysis, from its very beginning; he examines the most important steps, analyses critical points and contradictions. He points out how the choices opera ted by the institution have been mostly inspired by “political” motivations, often due to a self-conservation worry. This led to significant consequences on the fields of theory, technique and training. This trend drew psychoanalysis away from modern scientific and human sciences research criteria, causing its progressi ve emargination. It caused also the loss of the original contribution, given by
psychoanalysis in its early days, to the critique of society and culture. The author ends the article with his hope and proposal: that psychoanalysis can find from its own inside the strength for a rebirth, overcoming his current burocracy, and that looking back to its own roots it can reconnect a dialogue without bias with other scientific disciplines so that it can recover its role as a critical
theory.
Alexander, F. (1957), Psychoanalysis and Psychotherapy. New York.
Alexander, F., Selensky, S.T. (1965), Freud-Bleuler correspondence. Arch. Gen. Psychiat., 12:1-9.
Appy, J.G. (1986), Selbstentfremdung der Psycho-Analyse in der Gesundheitpolitik. Dpv Arbeitstagungsbericht, 13-30.
Balint, M. (1947), Il sistema formativo psicoanalitico. In, L'amore primario. Milano: Cortina, 1992.
Balint, M. (1958), Sandor Ferenczi's last year. Int. J. Psycbo-Anal., 39: 68-70. Barande, R. (1975), Quels psychanalystes. Et pur quel faire. Rev. Franc. Psychanal., 39: 225-246.
Basch, M.F. (1991), Die Zukunft der psychoanalytischen Methode. In Zeffichrift ßr psychoanalytische Theorie und Praxis, Sonderbeft, pp. 2-5
Bergeret, J., et al. (1987), Enquéte sur la pratique psychanalytique. Rev. Franc. Psychanal., 4: 1245-1268.
Bernfeld, S. (1952), Uber die psychoanalytische Ausbildung. Psyche, 38 (1984): 437-459.
Bertin, C. (1982), Marie Bonaparte. A Life. San Diego/New York/ London.
Bird, B. (1968), On candidate selection and its relation to analysis. Int. J. PsychoAnal., 49: 513-526.
Braun, K.F. (1992), Die gegenwärtige Ausbildungssituation in der Dpv im Spiegel einer Umfrage bei den Kandidaten des psychoanalytischen Institues Heidelberg-KarIsruhe. Psychoanal. Info., 38, April, pp. 3-14.
Clark, R.W. (1979), Freud. Milano: Rizzolì, 1983.
Cooper, A.M. (1980), The future of psychoanalysis: challenges and opportunities. Psycboanal. Q., 59: 177-196.
Cooper, A.M. (1984), Psychoanalysis at one hundred: Beginning of maturity. J. Amer. Psychoanal. Assn., 32: 245-267.
Cremerius, J. (1979), Robert Musil. Das Dilemma eines Schriftsellers vom Typus -poeta doctus - nach Freud. Psyche, 33: 733-772.
Cremerius, J. (1981a), Die Rezeption der Psychoanalyse in der Soziologie, Psychologie und Theologie im deutschsprachigen Raum bis 1940. Frankfurt.
Cremerius, J. (1981b), Freud bei der Arbeit über die Schulter geschaut. Seine Technik im Spiegel von Schulern und Patienten. Trad. it., Freud al lavoro: uno sguardo al di sopra della sua spalla. La sua tecnica nei resoconti di allievi e pazienti. In Il mestiere dell'analista, Torino: Boringhieri, 1985, cap. 9.
Cremerius, J. (1986), Spuresicherung. Psychoanalytische Bewegung un das Elend der psychoanalytischen Institution. Psyche, 40: 1063-1081. Trad. it., Alla ricerca delle tracce perdute. Il Movimento Psicoanalitico e la miseria dell'istituzione psicoanalitica. Psicoter. Sc. Um., XXI, 3: 3-34, 1987.
Cremerius, J. (1987), Der Einfluss der Psychoanalyse auf die deutschsprachige Literatur. Psyche, 44: 1-29. Trad. it., in Atti del convegno “La cultura psicoanalitica”, Trieste, 5-8 dicembre 1985. Gli Argonauti, 33, giugno, 1987.
Cremerius, J. (1989), Lehranalyse und Macht. Forum Psycboanal., 5: 190-208. Trad. it., Analisi didattica e potere. Psicoter. Sc. Um., XXIII, 3-28, 1989.
Cremerius, J. (1990a), Die hochfrequente Langzeitanalyse und die psychoanalytische Praxis. Utopie und Realität. Psyche, 44: 1-29.
Cremerius, J. (1990b), Sigmund Freud. Trasmissione radiofonica tenuta presso la Suddeutschen Rundfunk, 10 maggio, 1988.
Cremerius, J. (1992a), Der Dpv - Analyticher als Teilnehmer an der Kassenreglung. Forum Psychoanal., 8: 63-76.
Cremerius, J. (1992b), Die Zukunft der institutionalisierten Psychoanalyse. In M.Kuster (a cura di), Entfernte Wahrheit. Die Endlichkeit der Psycboanalyse. Tubingen, pp. 63-84.
Cremerius, J. (1993), Dichter auf der Analysecouch. In B.Goetz, O.Gutjar, J.Roebling (a cura di), Das verschweigene Ick. Pfaffenweiler, pp. 9-22.
Edelson, M. (1988), Psychoanalysis. A Theory in Crisis. Chicago: University of Chicago Press.
Eissler, R. (1965), Medical Orthodoxy and tbe Future of Psycho-Analysis. New York.
Eissler, K.R. (1969), Irreverent remarks about the present and the future of psychoanalysis. Int. j. Psycho-Anal., 50: 461-471.
Eissler, K.R. (1974), On some theoretical and technical problems regarding the payment of fees for psychoanalytic treatment. Int. Rev. Psycbo-Anal., 73-101.
Eitingon, M. (1925), Geschaftsprotokoll. Int. Zeitschr. Psycboanal., 11: 516.
Erdheim, M. (1987), Werm Institutionen verenden. Psychoanalytysches Seminar Zurich (a cura di), Between the Devil and the Deep Blue Sea. Freiburg i.B.
Erikson, E.H. (1957), The first analyst. In Freud and the 20th Century. New York.
Fonagy, P. (1993), Zusammenarbeit mit dem Präsidenten. In Ipa Newsletter, Sommerausgabe, pp. 9-10.
Franzen, P. (1982), Editorial. Councilfor the Advancement of Psychoanalytic Education. 2: 2.
Freud, A. (1938), Problemi dell'analisi didattica. In Opere, vol. 1, p. 269. Torino: Boringhieri.
Freud, A. (1966), The ideal psychoanalytic institute. Bull. Menn. Clin., 1971, 35: 225-239.
Freud, A. (1972), Schwierigeiten der Psycboanalyse in Vergangenbeit und gegenwart. Frankfurt.
Freud, A. (1976), Bemerkungen über Probleme der psychoanalytischen Ausbildung. Schrift. Anna Freud, München, 1980, pp. 2805-2810.
Freud, S. (1910), Le prospettive future della terapia psicoanalitica. OSF, vol. 6, pp.197-206. Torino: Boringhieri.
Freud, S. (1916-17), Introduzione alla psicoanalisi. OSF, vol. 8, pp. 195-611. Torino: Boringhieri.
Freud, S. (1919), Vie della terapia psicoanalitica. OSF, vol. 9, pp. 19-24.
Freud, S. (1921), Psicoanalisi e telepatia. OSF, vol. 9, pp. 345-361. Torino: Boringheri.
Freud, S. (1923), Due voci di enciclopedia: “Psicoanalisi” e “Teoria della libido”. OSF, vol. 9, pp. 439-462.
Freud, S. (1924), Breve compendio di psicoanalisi. OSF, vol. 9, pp. 587-605.
Freud, S. (1925), Autobiografia. OSF, vol. 10, pp. 75-141. Torino: Boringhieri. Freud, S. (1926), Il problema dell'analisi condotta da non medici. OSF, vol. 10, pp. 351-423. Torino: Boringhieri.
Freud, S. (1933), Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni). OSF, vol. 11, pp. 121-284. Torino: Boringhieri.
Fromm, E. (1970), La crisi della psicoanalisi. Milano: Mondadori, 1971.
Fürstenau, P. (1994), Neue Lebensformen erforden neue psychotherapeutische Orientierung. In P. Buchheim, M. Cierpka, T. Seifert (a cura di), Neue Lebensformen Zeitkranheit und Psycbotberapie. Berlin.
Gaddini, E. (1984), Changes in psychoanalytic patients up to the present day. In R.S. Wallerstein (a cura di), Changes in Analysis and in Their Training. International Psychoanalytic Association, Monograph series, n. 4, 6-19.
Glover, E. (1937), Die Grundlagen der therapeutischen Resultate. Int. Zeitschr. Psychoanal., 23: 42-50.
Graf, M. (1942), Reminescene of Professor Sigmund Freud. Psychoanal. Q., 11: 465-476.
Greenson, R.R. (1967), Tecnica e pratica psicoanalitica. Milano: Feltrinelli, 1981.
Groen Prakken, H. (1981), Die Psychoanalysc in den Niederlanden: Opfer wiertschaftlicher Depression. Bull. Eur. Psychoanal. Fed., 17: 105-107.
Groen Prakken, H. (1984), Regierung un psychoanalytische Ausbildung. Bull. Eur, Psychoanal. Fed., 23: 101-109.
Hamburg, D. (1967), Report of the committee on central fact gathering data of the American Psychoanalytic Association. J. Amer. Psychoanal. Assn., 15: 841-961.
Holder, A. (1984), Psychotherapie und staatliches Gesundheitwesen in England. In H. Bach, U. Ebebald, J. Weigelt (a cura di), Psychoanalyse, Psychotberapie, Offentlichkeit. Gottingen.
Holt, R.R. (1990), Una perestrojka per la psicoanalisi: crisi e rinnovamento. Psicoter. Sc. Um., XXIV, 3: 37-65, 1990.
Jacoby, R. (1983), Die Verdrängung der Psychoanalyse oder der Triumph des Konformisus. Trad. it. in Il disagio della psicoanalisi. Roma: Astrolabio, 1987.
Jappe, G. (1983), Bemerkungen über die Probleme der psychoanalytischen Ausbildung. In S.O. Hoffmann (a cura di), Deutung und Beziebung. Frankfurt.
Jaspers, K. (1950), Il medico nell'età della tecnica. Milano: Cortina, 1991.
Jones, E. (1953-57), La vita e le opere di Sigmund Freud. 3 voll. Milano: Il Saggiatore, 1962.
Kernberg, O.F. (1984), Problemi istituzionali del training psicoanalitico. Psicoter. Sc. Um., XXI, 4: 3-32, 1987.
Kernberg, O.F. (1993), Aktuelle Probleme der Psychoanalyse. Bull. Wiener PsycboanaL Ver., 1: 5-21.
Kernberg, O.F. (1994), Der gegenwärtigen Stand der Psychoanalyse. Psyche, 48: 15-46.
Klauber, j. (1980), Die Identität des Psychoanalitikers. In Schtvierigkeiten in der analytischen Begegnung. Frankfurt.
Klüwer, R. (1980), Der Einfluss von Theorie und Praxis der Psychotherapie auf die psychoanalytische Ausbildung. Relazione presentata alla conferenza sulla formazione, Londra, 1978.
Knight, R. (1953), The present status of organized psychoanalysis in the United States. j. Amer. psychoanal. Assn., 1: 197-221.
Kohut, H. (1969), Forschung in der psychoanalytischen Ausbildung. Ein Memorandum. Psyche, 25: 738-757.
Kohut, H. (1973), Die Zukunft der Psychoanalyse. Frankfurt.
Kubie, L.K. (1956), Psycboanalyse ohne Geheimnis. Reinbek.
Kuhn, T.S. (1967), La struttura delle rivoluzioni scientificbe. Torino: Einaudi, 1969.
Kuster, M. (1993), Entfernte Wahrheit. Von der Endbchkeit der Psychoanalyse. In: Psychoanalytisches Seminar Zurich. Tubingen.
Langer, M. (1986), Von Wien nach Nicaragua. Freiburg i. Br.
Leeuw, Pj. (1978), Modern times und die Berufaufsubung des Psychoanalytikers in der heutigen Zeit. In S. Drews (a cura di), Provokation und Toleranz. Frankfurt.
Limentani, A. (1986), Presidential address. Variation on some Freudian themes. Int. j. Psycbo-Anal., 67: 235-243.
Little, M. (1991), Uber die bedeutung vom Regression und Abhangigkeit. Psyche, 45: 914-930.
Lohmann, H.M., Rosenkotter, L. (1982), Psychoanalyse in Hitler DeutschIand. Wie war es wierklich? Psyche, 36: 961-988.
Loch, W. (1974), Der Analytiker als Gesetzgeber und Lehrer. Legitime und iflegitime Rollen? Psyche, 28: 431-460.
McLaughlin, j. (1967), Addendum to a controversial proposal. Some observations on the training analysis. Psycboanal. Q., 36: 230-247.
Meerwein, F. (1978), Die Identität des Psychoanalytikers. Zeitscbr. Psychosom. Med., 8: 29-44.
Merton, K.R. (1949), Theory and Social Structure. Glencoe, 1962.
Morgenthaler, F. (1965), Mitteilung von Dr. Ph. Sarasin an Dr. Morgenthaler. Bull. Scbweiz. Gesell. Psychoanal., 1: 7.
Parin, P. (1978a), Lo studio del “fattore soggettivo”. Psicoter. Sc. Um., XX, 3: 145-157, 1986.
Parin, P. (1978b), Warum die Psychoanalytiker so ungern zu brennenden Zeitproblemen Stellungnehmen? Eine ethnologische Betrachtung. Psyche, 32: 385-399.
Parin, P. (1986), Die Vefluchtigung des Sexuellen in der Psychoanalysc. In Psychoanalytische Seminar Ziirich (a cura di), Sexualität. Frankfurt.
Parin, P. (1990), Die Beschadigung der Psychoanalysc in der angelsächsischem Emigration und ihre Ruckkehr nach Europa. Psyche, 44: 191-202.
Peck, M.W. (1940), A brief visit with Freud. Psychoanal. Q., 9: 206.
Popper, K.R. (1942), La società aperta e i suoi nemici. Roma: Armando, 1973.
Pulver, S.W. (1978), Erhebungen über die psychoanalytische Praxis. Tendenzen und Konsequenzen. Psyche, 38 (1984): 63-82.
Roazen, P. (1975), Freud e i suoi seguaci. Torino: Einaudi, 1998.
Rotmarm, M. (1988), Der Einfluss von Haeufigkeit und Dauer der Sitzungen auf die Entwiklung eines kurativen psychoanalytischen Prozess. Referat der Tagung der Europaischen Psychoanalytischen Federation. Bull. Eur. Psychoanal. Fed., 31: 151-164.
Sachs, H. (1930), Die Lehranalyse. In Zehn Jahre Berliner Psycboanalytiscbes Institut. Frankfurt 1982.
Sachs, H. (1945), Freud, maestro e amico. Roma: Astrolabio, 1973.
Sandler, J. (1983), Die Beziehung zwieschen psychoanalytischen Konzepten und psychoanalytischer Praxis. Psyche, 37: 577-595.
Sandler, J. (1989), Psychoanalyse und psychoanalytische Psychotherapie. Das Probleme der Abgrenzung. Dpv Info, 5: 1-5.
Sandler, J. (1990), Die Zukunft der Psychoanalyse. In H.V. Werthmann (a cura di), Herausforderung jur die Psychoanalyse. Munchen.
Sandler, J. (1991), Mitteilungen des Prásidenten Prof. J. Sandler. Ipa Newsletter, XXII, 2: 1-3.
Speier, S. (1983), Gedanken zur Ausbildung oder Wie man Analytiker wird. In HM Lohmann (a cura di), Das Unbebagen in der Psychoanalyse. Eine Streitschrif. Frankfurt.
Steiner, R.C. (1985), Some thoughts about tradition and change arising from an examination of the British Psychoanalytic Society's controversial discussions (1943-44). Int. Rev. Psycho-Anal., 12: 27-61.
Stepansky, P. (1989), Margaret Mahler. München.
The San Francisco Psychoanalytic Institute (1990-91), Training Program in Psycboanalysis. San Francisco.
Thomä, H. (1991), Ideen und Wirkficheit der Lehranalysc. Ein Plaedoyer fur Reformen. Psyche, 45: 358-433 e 481-505.
Thomä, H., Kächele, H. (1985), Trattato di terapia psicoanalitica. Vol. L Fondamenti teorici. Torino: Bollati Boringhieri, 1990.
Wallerstein, R.S. (1986a), Forty-two Lives in Treatment. New York.
Wallerstein, R.S. (1986b), Psychoanalysis as a science. A response to new challenges. Psychoanal. Q., 55: 414-451
Wallerstein, R.S. (1988), One psychoanalysis or many? Int. J. Psycko-Anal., 69, 5-21. Trad. it., Gli Argonauti.
Wallerstein, R.S. (1991), Psychoanalytic education and research: a transformative proposal. Psychoanal. Inq., 11: 196-225.
Wallerstein, R.S., Weinsbel, E.M. (1989), Tbc future of psychoanalysis. Psycboanal. Q., 58: 341-371.
Winnicott, D.W. (1974), Sviluppo affettivo e ambiente. Roma: Armando, 1976.
Wittenberger, G. (1987), Von der Selbstregulation zum Prufungskolloquium. Dpv Arb., 135-144.
Vai al sito ufficiale della rivista Psicoterapia e Scienze Umane
© POL.it 2000 All Rights Reserved |