

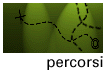



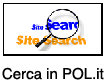
 |
 |
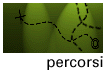 |
 |
 |
 |
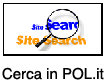 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Attenzione: questo Ė un vecchio file, che conteneva la quarta parte dell'articolo di Benedetti che era diviso in quattro parti, successivamente accorpate alla prima. Torna quindi all'indirizzo: http://www.pol-it.org//ital/riviste/psicouman/benedetti.htm
Gaetano Benedetti
Benedetti, C. (1988): Annahmen zu einer axiomatischen Verstandnis von Zeichen und Symbol. In G. Benedetti, U. Rauchfleisch) Welt der Symbole, Vanderhoeck, Gottingen, 1988. Benedetti, G. (1988): Das Symbol in der Psychopathologie und in der Psychotherapie der Schizophrenie. In, ibidem pag. 214-224. Benedetti, G. (1998): Botschaft der Traume, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. Bleuler, E. (1911) Dementia Praecox oder die Gruppe der Schizophrenien. In B. Aschaffenburg (a cura di), Handbuch der Psychiatrie, Leipzig/Wien, Deuticke. Cajal, Santiago Ramon, in G. D. Fischbach (1992) Mente e Cervello, Milano, Le Scienze. Crick, F. and Mitchison, G. (1983): On the function of Dream Sleep, Nature, 304-279-296. Crick, F. e Koch, Ch. (1992), Il Problema della Coscienza. Mente e Cervello, Milano, Le Scienze, pp. 126-133. Dement, W. (1960) The effect of dream deprivation, Science, 131, 1705-1707. Damasio, A.R. e H. (1992), Cervello e Linguaggio. Mente e Cervello, Milano, Le Scienze. Federn, P. (1953), Ego. Psychology and the Psychoses, London, Imago. Fischbach, G.D. (1992), Mente e Cervello, Milano, Le Scienze. Freud, S. (1900-1942), Die Traumdeutung, Imago, London. Goldman-Rakic, P.S. (1992), La Memoria di lavoro, in Mente Cervello, Milano, Le Scienze, pp.291, 76-85 Kimura, D. (1992): Differenze sessuali a livello cerebrale, in Mente e Cervello, Milano, Le Scienze, 291, 86-95 Klein, M. (1956), New Directions in Psychoanalysis, New York, Basic Books. Jackendoff R. (1987), Consciousness and the Computational Mind, The MIT Press/Bradford Books. Jung, C.G. (1921), Psychologische Typen, Zurich (trad. it.: Tipi psicologici. In: Opere di Carl Jung, Vol. 6. Torino: Boringhieri, 1969) Jacobson, E. (1964) The Self and the Object World, New York , Intern. Univ. Press (trad. it.: Il SČ e il mondo oggettuale. Firenze: Martinelli, 1974). Mahler, M.S. (1970): On Human Symbiosis and the Vicissitudes of Individuation, New York, Intern. Univ. Press (trad. it.: Le psicosi infantili. Torino: Boringhieri, 1972). Kohut, H. (1971), The Analysis of the Self, New York (trad. it.: Narcisismo e analisi del SČ. Torino: Boringhieri, 1976). Kris, E. (1953): Psychoanalytical Explorations in Art, London. Lacan, J. (1966): Ecrits, Paris, Ed. de Seuil. Lévy-Bruhl, L. (1966), How Natives think, New York (Ed. orig.: Les fonctions mentales dans les sociéetées inférieurs, 1910). Mircea Eliade (1973), Die Sehnsucht nach dem Ursprung, Wien, Europaverlag. Peciccia, M. (1998), Der Traum in der Psychotherapie der Schizophrenie, in: G. Benedetti, Botschaft der Träume, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. Piaget J. (1937). La construction du rČel chez l'enfant. Neuchtel et Paris: Delachaux et NiestlČ (trad. ingl.: The construction of reality in children. Basic Books, New York, 1954; trad. it.: La costruzione del reale nel bambino. Firenze: La Nuova Italia, 1979). Rosenfeld, H. (1969), Contributions to the Psychopathology of Psychotic States, in P. Doucet C. Laurini, Problématique de la psychose, Amsterdam ,Excerpta Medica,. Sacks, O. (1990): Vedere Voci, Milano, Adelphi. S. Gregorio, in C. Butler (1970), Il misticismo occidentale, Bologna, Il Mulino. Stern, D.N. (1985), The Interpersonal World of the Infant, New York, Basic Books (trad. it.: Il mondo interpersonale del bambino. Torino: Bollati Boringhieri, 1987). Vialou Denis (1992), Fruhzeit des Menschen, Munchen, C.H. Beck. Winson, J. (1986), Brain and Psyche: The Biology of the Unconscious, New York, Garden City.
Attraverso una disanima di fenomeni sia neurofisiologici che psicologici, e con riferimento sia alla recente ricerca neuropsicologica sia alle nostre esperienze di psicoterapia, specie con pazienti psicotici, si rileva la grande importanza del pensiero figurativo nella genesi della mente e nella strutturazione della comunicazione. NOTE: 1 È qui che si innesta la meravigliosa capacità sostitutiva del nostro cervello nel campo delle immagini, quando una data categoria di esse è preclusa da danno cerebrale. Nel suo libro L 'uomo che scambiò sua moglie con un cappello Oliver Sacks ci descrive un paziente affetto da agnosia visiva che non poteva riconoscere i suoi studenti mentre questi stavano seduti, ma subito li riconosceva se essi si muovevano, perché realizzava "la musica dei corpi". In "Vedere voci" Sacks ci descrive la capacità acutissima di sviluppare l'esperienza visiva in assenza di quella acustica in soggetti sordi.2 Un problema che qui insorge viene formulato da Crick e Koch (1992): "(SIGMA)se è possibile essere coscienti di più di un oggetto nello stesso tempo. Se tutti gli attributi di due o più oggetti fossero rappresentati da neuroni che scaricano rapidamente, potrebbero essere confusi". Von Der Malsburg ha qui proposto che i neuroni associati con qualsiasi oggetto si attivino tutti in sincronia (nella misura, cioè, che i loro tempi di scarica siano correlati, ma fuori sincronia rispetto a quelli che rappresentano altri oggetti. Non è escluso che con quest 'ordine di pensiero ci muoviamo verso una parziale comprensione della confusione psicotica delle immagini.3 Questo è visibile in un tipo di simbolizzazione che è particolarmente proprio della nostra epoca. Per esporre brevemente questo concetto dirò che due forme classiche di simbolizzazione del passato; una è l 'immagine concreta esistente in natura, che rimanda ad un'altra astratta (ad es. l'acqua che lava come simbolo dello Spirito che purifica); l'altra è l'immagine non esistente in natura, ma strutturate secondo immagini reali, di cui il simbolo, componendole assieme, condensa le qualità (ad es. il "drago" rappresentato nella porta di Ischtar a Babilonia e ora al museo Pergamon di Berlino ha gli artigli dell'aquila, le zampe del leone, il collo e la testa di quel che potremmo oggi chiamare un dinosauro, la coda eretta come un serpente; esso è un simbolo che raccoglie in sé tutta la forza animale di un progetto fantastico. Nelle arti figurative del nostro secolo appare una terza forma di simbolizzazione, appena accennata in epoche precedenti, ove la forma concreta, simbolizzante, è un neologismo figurativo, che può simboleggiare qualsiasi cosa o nulla a secondo della mente che la medita. Siamo di fronte alla ricerca di una libertà di simbolizzazione, che mostra una evoluzione del pensiero umano verso orizzonti che non ci sono noti.Vai al sito ufficiale della rivista Psicoterapia e Scienze Umane


|