

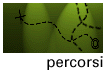



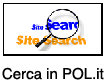
 |
 |
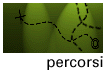 |
 |
 |
 |
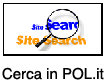 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Attenzione: questo Ë un vecchio file, che conteneva la seconda parte dell'articolo di Benedetti che era diviso in quattro parti, successivamente accorpate alla prima. Torna quindi all'indirizzo: http://www.pol-it.org//ital/riviste/psicouman/benedetti.htm
Gaetano Benedetti
II. IL PENSIERO FIGURATIVO NEL SOGNO Il sogno come reminiscenza Il pensiero figurativo è in particolare proprio dei popoli primitivi. Levi Bruehl (1966) ci riferisce che gli abitanti della Tanzania "non avevano parole per esprimere le idee astratte.. non potevano esprimere qualità come duro, soffice, rotondo, alto, basso etc. Per esprimere "duro" dicevano "simile ad una pietra", per "alto" "gambe lunghe", per "rotondo" "simile ad una palla", o "simile alla luna", e così via, sempre accompagnando le parole con gesti intesi a mettere dinanzi agli occhi dellíinterlocutore líoggetto descritto". Quando avviene "una transizione a tipi mentali superiori, questo linguaggio deve essere abbandonato; concetti logico-astratti generali, privi di immagini, ne sostituiscono i "concetti-immagine", vividi, ricchi di particolari sensoriali" (Sacks). Ora, è stato più volte detto, ritenuto, che nel sogno si continui questíepoca arcaica della mente umana; che il sogno sia una regressione sia al passato individuale anche più lontano, sia anche a quello archetipico dellíumanità (e non mancano i neurofisiologi che postulano un tipo regressivo di preorganizzazione neuronale). Il filosofo Nietzsche riteneva ad es. che nel sogno "si perpetua uníepoca primitiva dellíuomo, che non potremo più raggiungere per via diretta". Riflessioni simili si trovano anche in Freud, il quale riteneva che ciò che oggi è legato simbolicamente doveva un tempo lontano rappresentare uníidentità (vedi il suo XII saggio metapsicologico del 1985, solo recentemente ritrovato). La relazione simbolica veniva vista da lui come un residuo di una più profonda identità arcaica. Siffatte ipotesi sono difficilmente confermabili dal punto di vista storico, mentre dal punto di vista psicologico esse non sono né testabili né falsificabili. Noi non potremo mai conoscere per bocca dellíinfante cosa ci sia, nella psiche umana, al di là di quella "rimozione primaria" (Lacan) che ha scisso alle origini la mente fra oggetto e soggetto, fra il cosiddetto "reale" (Lacan) e il simbolo; líesperienza "globale" di Stern equivale, nel senso della non conoscibilità, al "noumeno" di Kant. Ipotesi psicologiche non verificabili hanno solo la funzione (significativa) di costruire modelli della vita psichica su cui organizzare le esperienze della psicoterapia. È certo intanto che il pensiero figurativo, sia immaginario che simbolico, è proprio del sogno come di nessuníaltra forma di attività mentale. È vero, come esporremo in seguito, che in situazioni particolari del pensiero umano, come la contemplazione religiosa, estetica, meditativa, líImmaginario e il Simbolico strutturano largamente lo stato mentale; ed è altresì vero che neanche il pensiero astratto può fare a meno di elementi simbolici. Ma dove, come nel sogno, tutto è immagine e simbolo? La psichiatria conosce particolari alterazioni della coscienza, dette "oniroidi", ove la mente pensa solo per immagini. Ma proprio la qualifica di "oniroide" documenta la loro vicinanza al sogno, al pensiero che dal termine greco vien detto nel tentativo di comprendere il significato del sogno (problema antico di millenni, battezzato in scienza dal 1900 con Freud e da allora, come tutti i grandi problemi della mente, mai definitivamente risolto) muovo da un progetto fisiologico: quello di concepire le funzioni del sogno nel triplice ventaglio della memorizzazione, della simbolizzazione e dellíattività ristoratrice del sogno. Memorizzazione La scoperta fondamentale della psicoanalisi è stata con Freud quella di accedere al passato anche infantile, e non più cosciente, attraverso la memoria latente del sogno. Per lo più questa memoria è cifrata, per motivi che discuteremo in seguito; ma essa può anche, in casi singoli e istruttivi, sorprenderci con una vividezza di particolari, di cui nulla era rimasto nel ricordo della veglia. Una paziente in psicoterapia, che accusava disturbi di natura psicosomatica, sogna di essere una bimba di tre anni, accanto a sua sorella maggiore, tredicenne. Lei si trova in un locale sconosciuto, ove irrompono tre giovani che abusano sessualmente di lei e della sorella. La paziente si sveglia dal sogno perplessa; non riesce a ricordare nulla che vada in direzione del sogno. Si decide allora a raccontarlo alla sorella, la quale le conferma che le immagini del sogno corrispondevano perfettamente alla lontana realtà, di cui alla piccola per un riguardo non era stato fatto più cenno. Non solo il numero dei ragazzi che fecero violenza alle bambine, ma perfino i particolari del locale raffigurato dal sogno corrispondevano al ricordo della sorella maggiore. Questo è un esempio di memorizzazione singolare, senza alcuna trasformazione simbolica. In che modo il sogno può favorirla? Nellíuomo, eludendo le resistenze emotive al ricordo, le quali sono maggiormente legate allíIo sveglio, all'Io morale del soggetto. Da un punto di vista neurofisiologico questíultimo aspetto non può certamente apparire, ma vi è un riscontro interessante alla teoria della memorizzazione. Cito Wilson, di cui riferisco la più recente formulazione del 1991. Il suo assunto fondamentale è quello che i sogni rappresentano nei mammiferi e nellíuomo un meccanismo di memorizzazione delle esperienze della veglia, che vengono così elaborate in immagini stabili, per divenire base comparativa di nuove esperienze. Líautore ha osservato che un caratteristico segnale neuroelettrico, da lui chiamato "ritmo theta", compare durante la veglia nel cervello dellíanimale, non quando questo esibisce un comportamento determinato geneticamente, come líalimentazione e líattività sessuale, ma solo quando esso reagisce a condizioni di vita ambientale. Nel sonno tale ritmo compare durante líattività onirica nella regione dellíippocampo, notoriamente coinvolta essenzialmente nel processo di memorizzazione. Ecco il reperto che ha indotto líautore allíaffermazione che il "ritmo theta" riflette un processo nervoso mediante il quale informazioni essenziali alla sopravvivenza della specie, raccolte durante il giorno, verrebbero ulteriormente memorizzate durante il sonno, proprio attraverso il sogno. La rete neocorteccia-ippocampo è sottoposta al "ritmo theta" durante il sogno e senza questo, in seguito alla sua abolizione sperimentale, il sogno scompare. Le informazioni cerebrali, ci dice Wilson, vengono suddivise in "pacchetti" di 200 mill isecondi ciascuno dal "ritmo theta". Poiché gli animali non posseggono il linguaggio, le informazioni che essi elaborano sono necessariamente solo sensoriali.Coerentemente alla nostra discendenza dai mammiferi, anche nellíuomo i sogni sono sensoriali, soprattutto visivi, e ne assumono la forma di una narrazione verbale [...] Sempre in conformità con il ruolo di memorizzazione, non cíè alcuna necessità funzionale che questo materiale diventi coscio; ed infatti vi sono individui che sognano raramente in confronto di altri. Ma non vi è neppure motivo per cui il contenuto dei sogni non debba giungere alla coscienza, soprattutto se il risveglio avviene durante o subito dopo la fase di sonno REM. [Wilson conclude con il seguente concetto] qualunque possa essere il suo ruolo nellíetà neonatale, ritengo che allíetà di due anni (quando líippocampo, che è ancora in fase di sviluppo, diventa funzionale) il sonno REM assuma la sua funzione di permettere il processo di memorizzazione. Il substrato cognitivo basilare della memoria è il paradigma del mondo reale, con il quale le successive esperienze dovranno essere confrontate ed interpretate. Líorganizzazione in forma di memoria di questa infrastruttura richiede una fase di sonno particolarmente lunga, come appunto nel bambino. Desidero amplificare qui il concetto di memorizzazione proposto da Wilson in termini strettamente fisiologici. Direi che nellíuomo adulto il ricordo del passato remoto non serve alla sopravvivenza della specie o dellíindividuo, ma alla creazione dellíidentità storica del soggetto. Tale identità storica può anche rimanere in parte inconscia e riemergere nel sogno. Ricordi dellíinfanzia (la strada del paese natio, líedera rampicante sul muro di casa) affiorano talora in certi sogni con una tale vividezza e precisione di particolari, quale nessuna memoria della veglia sa renderci. Il senso di gioia provato al risveglio è forse dovuto proprio al vissuto di un recupero integrale della memoria: nulla del passato va totalmente perduto, nellíinconscio rimane intatta la storia dellíindividuo come mostrano certi particolari e brevi stati di coscienza in individui esposti al confronto con la morte: in un flash di consapevolezza tutto il passato della vita sembra riemergere dallíInconscio e viene sintetizzato anche in un brevissimo arco di tempo, come mai possibile nella veglia usuale. È nella simbolizzazione che consiste il fulcro della funzione psicodinamica del sogno, il quale si distingue dalla veglia nel fatto che quasi tutto in esso è simbolo; tanto che ci è permessa líipotesi essere il sogno un organizzatore fondamentale del pensiero simbolico nellíuomo. Toccheremo in seguito il problema, cosa intendiamo per simbolo, parlando del pensiero umano nella veglia. Qui vogliamo anzitutto affermare che la grande capacità sintetica del simbolo onirico sta nella sua possibilità di ricostruire eventi passati in immagini del presente. Molto spesso noi ci troviamo, nei nostri sogni, in un presente indefinito ove tuttavia si attualizzano grandi problemi del passato. Trattasi, come io la definisco, di una attualizzazione potenzialmente trasmutativa, perché nella ripetizione simbolica si apre uníarea di possibile nuova decisionalità entro un evento già definito dai parametri del passato. Noi abbiamo la possibilità (che è quella del nostro inconscio, non della nostra volontà) di reagire nuovamente e diversamente di prima a qualcosa che in realtà ci ha già determinati. Tale possibilità viene raccolta quando il soggetto fa nel sogno qualcosa che non ha potuto fare mai nel suo passato e che gli permette, in uníarea di dipendenza da aspetti coercitivi dellíesistenza, un vissuto di liberazione e quindi anche una nuova autonomia psichica. È in questo significato della simbolizzazione che rientra il celebre concetto freudiano della soddisfazione del desiderio proibito. Freud ha visto il desiderio soprattutto dal punto di vista istintuale, e la proibizione come censura morale del Super-io. Il sogno, che permette la soddisfazione del desiderio nelle vesti di simbolo, ossia in modo nascosto, ed evita perciò il conflitto con il Super-io, è un "guardiano del sonno". Pur accettando il modello di Freud, suffragato da uníimponente casistica clinica di decenni di ricerca psicoanalitica, e che ha inoltre il grande merito di avere introdotto i concetti fondamentali di una psicologia dinamica nello studio dei sogni e dellíinconscio, desidero allargarlo nei termini sopraesposti. La soddisfazione del desiderio rientra nella realizzazione del sé, il suo motore non è solo il principio del piacere, ma la spinta ad una autonomia della psiche in uníesistenza che la limita e che viene trasformata nel sogno. Il simbolo onirico traveste il desiderio proibito perché esso è il risultato di processi psichici difensivi quali la condensazione di immagini diverse, la contaminazione di uníimmagine con altre, líuso della "pars pro toto", la negazione dellíintenzionalità nascosta. Abbiamo qui tutta la "tecnica inconscia" dellíoccultamento simbolico, così ben scoperta da Freud, che forse nullíaltro di essenziale è stato detto, da lui in poi, in questo campo.Ma la costruzione del simbolo onirico è ambigua: il simbolo non solo occulta, ma anche, allíopposto, rivela, e ciò attraverso un processo, che io denomino la "sensorializzazione dellíesperienza". Dal resto diurno fino al pensiero archetipico, tutto appare nel sogno sotto forma di immagini visive. E poiché noi abbiamo cominciato a pensare non razionalmente, ma per immagini, allora proprio la riduzione dellíesperienza allíimmagine conferisce ad essa una drammaticità espressiva ed una evidenza di pensiero altrimenti impossibile. Talora il desiderio onirico non è affatto proibito ed ha bisogno del sogno solo per divenire trasparente a se stesso, indimenticabile e certo, attraverso la radicalizzazione dellíimmagine. Ecco un esempio fornitomi da un mio paziente il analisi: Vidi Lei, prof. Benedetti, sulla scala della mia abitazione. Eravamo in tre: Io, Lei ed un giovane che in parte si assimilava e in parte si distingueva da me. Io e questo giovane eravamo curvi ad un improbo e faticoso lavoro: quello di estrarre sacchi di immondizia dallo sportello della colonna-condotta vuota ove si gettano i rifiuti che giungono così al raccoglitore situato nel sotterraneo. Il condotto si era ingorgato e noi dovevamo estrarre da quel pertugio-botola i pacchi di immondizia gettativi dentro, che per la loro eccessiva dimensione avevano ostruito il condotto. Líoperazione faticosa e ripugnante riusciva ed io consegnavo a Lei, prof. Benedetti che mi stava accanto in piedi, un sacchetto azzurro di plastica, che contrariamente allíimmondizia circostante era pulito e conteneva un raccoglitore trasparente e sigillato, pieno di un liquido che pensavo a prima vista essere acqua distillata - e che poi si rivelavano essere lacrime. Quale forza di espressione in questo sogno transferale, nel simbolo dellíimmondizia, che faticosamente viene estratta dal passato durante la psicoanalisi, nellíattualizzazione di questo passato attraverso líimmagine del giovane, il paziente di un tempo che lavora a fianco del paziente anziano di adesso, personificato dallíIo sognante. E quale profonda consapevolezza è nel simbolo, che è anzitutto il Sé del paziente, presente e passato, a compiere gran parte del lavoro analitico, mentre il compito dellíanalista è anzitutto quello di sapergli stare accanto. In ultimo abbiamo líimmagine del sacchetto pulito e pieno di lacrime, il quale simboleggia la consapevolezza che dal profondo non viene estratta solo immondizia (la miseria della neurosi) ma dolore umano concreto come il pianto; il quale anchíesso viene consegnato al partner, anzi diviene trasparente ai due (sembrava essere acqua distillata, nel linguaggio del simbolo) proprio attraverso gli atti della comunicazione e delle identificazioni reciproche. Come sarebbe stato possibile esprimere tutto ciò senza il simbolo? La simbolizzazione qui non copre nulla, rende solo evidente quel che nella sua affettività sta al di là della parola che non può venire acquisito dalla mente che attraverso líimmagine. In conclusione, la simbolizzazione del sogno ci mostra uníimmagine ambigua che ora rivela e ora nasconde, ora memorizza e ora spersonalizza, ora concretizza e ora astrae, ora scinde e ora condensa, ora estranea e ora personifica, ora oggettifica e ora soggettifica, ora comunica ciò che può esser riportato ad un resto diurno e ora si rifà ad un passato remotissimo. Non mi è possibile, per motivi di spazio, sostare su queste polarità oniriche che ora si escludono e ora si condizionano a vicenda, ora sono dialettiche ed ora sinergiche; mi limiterò solo ad accennare allíalternativa di oggettificazione e soggettificazione. Il sogno di una donna che nel sonno immagina di partorire un bimbo può esprimere da un canto un desiderio di maternità (interpretazione di oggetto = il bimbo) o anche il simbolo della nascita di un nuovo Sé verso una forma più alta di autorealizzazione (interpretazione di soggetto, messa in particolare a fuoco da Jung). Il sogno ci mostra così una struttura antinomica della conoscenza arcaica, che si contrappone a quella lineare del pensiero razionale. La proposizione razionale ha una struttura binaria, è una scelta fra il sì e il no; líimmagine onirica contiene il sì e il no, è ambigua e perciò interpretabile diversamente. La "sfocatezza" del sogno è visibile anche nel fatto che le strutture mentali di spazialità, temporalità, causalità, ritenute da Kant un a priori della mente umana, possono apparire anche cancellate nel sogno. La doppia valenza del linguaggio onirico si riflette naturalmente nella logica interpretativa, che ne condivide líambiguità, tanto che un critico della psicoanalisi (Jaspers) le ebbe a rimproverare la transmutabilità interpretativa. Ma proprio tale partecipazione del pensiero interpretativo alla struttura della vita soggettiva profonda, che non è riducibile alla obbiettività razionale e diviene comprensibile nellíidentificazione con líaltro, ribalta la "debolezza scientifica" nella forza e penetranza della comunicazione. Il sogno come ristoro dellíattività mentale La scoperta di Dement del 1959 ci aveva fatto ritenere che líesperienza onirica nellíuomo occorresse solo durante certe fasi del sonno, caratterizzate da una particolare frequenza dellíattività elettrica del cervello, registrabile elettroencefalograficamente e simile allíattività della mente durante la veglia. Soggetti svegliati sperimentalmente durante tali fasi, dette REM perché caratterizzate da "rapid eye mouvements" (che sembrano esplorare lo spazio del sogno) ci dicono nove volte su dieci di sognare. Ma negli anni successivi si è appreso che esistono anche sogni NREM, i quali intervengono cioè anche nelle altre fasi del sonno; sembra che essi, anche formalmente e affettivamente diversi, siano più difficili da ricordare, perché solo una persona su tre, svegliate in tali momenti, è capace di riprodurli. Ora, data líimpossibilità della regolarità del ricordo anche nella situazione sperimentale, nulla vieta di ipotizzare la possibilità di una esperienza onirica continua durante tutto il sonno (Strauch e Meier, 1992).È possibile avanzare qui la tesi che, come la veglia è una continua introiezione di percezioni che sovraccaricano la ricettività psichica così i sogni consistono in proiezioni di immagini da cui l'Io dormiente si dissocia. Ricordo líesperienza di ristoro che si fa passando da uníora insonne, in cui i più banali pensieri e ricordi si affollano alla mente, in un dormiveglia in cui ci si osserva e ci si accorge, entrando nel pensiero immaginario del sogno, come immagini oniriche dissociate dallíIo si susseguono secondo ordini loro propri, senza che líIo semidormiente debba costruirle egli stesso. Il flusso dellíattività mentale continua nel sogno, ma líIo, come sdoppiato, ne sta al di fuori, si guarda allo specchio anche quando agisce nel sogno e riposa. La scissione fisiologica fra Io dormiente e Io agente nel pensiero simbolico del sogno permette quella funzione salutare che è il distacco dalla realtà che si riflette nel simbolo. Tale distacco è inoltre tanto maggiore, quanto più puntiforme è la coscienza del sogno, dellíimmagine che torna a dissolversi appena emersa dallíInconscio. Il fatto che la maggior parte dei sogni viene dimenticata, come sempre sottolineato nel loro studio sperimentale attraverso la tecnica del risveglio, trova qui una nuova risposta: non solo la memorizzazione, come proposto da Wilson, ma anche la dimenticanza, come proposto da Crick e Mitchison è importante, e la funzione del sogno, che come tutti i "processi primari della psiche" (Freud) si stende fra estremi opposti e li riunisce dialetticamente, è complessa. Secondo i due autori citati il sonno onirico servirebbe a cancellare regolarmente le associazioni spurie, supponendo che la neocorteccia possa trovarsi nella veglia in sovraccarico per la grande quantità di informazioni in arrivo. Le onde PGO raggiungono, secondo questa teoria, la neocorteccia e provocano la cancellazione, ossia il disapprendimento. "Sogniamo per dimenticare". È possibile applicare tale teoria su un doppio livello: da un canto a proposito di quegli individui che sognano solo raramente; il loro sonno è una cancellazione continua di immagini appena emersi in sogni subito dimenticati. Dallíaltro a proposito di quegli individui che soffrono di sogni ripetitivi, ove non è possibile vedere il soddisfacimento di un desiderio istintuale, mantenuto dalla teoria di Freud. Sono spesso rimasto stupito nellíascoltare dalla bocca di siffatti pazienti, come nulla li avrebbe resi tanto infelici quanto il perdere i loro sogni infelici! Mi sono poi reso conto che qui opera un meccanismo psichico analogo a quello che Freud ebbe a individuare nellíesperienza del lutto: líincontro con il ricordo della perdita permette líusura progressiva della rappresentazione della perdita, e così la dimenticanza. Vai al sito ufficiale della rivista Psicoterapia e Scienze Umane


|