 |
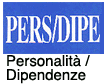 |
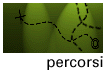 |
 |
 |
 |
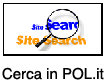 |
 |
|
|||||||
|
|
ATTACCAMENTO E PSICOPATOLOGIA TRA CLINICA E RICERCA. APPLICAZIONE DELL'ADULT ATTACHMENT INTERVIEW AD UN GRUPPO DI DONNE TOSSICODIPENDENTI Graziella Fava Vizziello***, Alessandra Simonelli**, Ilaria Petenà*. *** Professore di Psicopatologia dello Sviluppo, Università degli Studi di Padova. ** Dottore di Ricerca, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova. * Psicologo tirocinante, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova. Discussione Da quanto osservato, emerge una sostanziale differenza tra le distribuzioni delle categorie di attaccamento nei due gruppi considerati. Rispetto, infatti, sia a tre che a quattro categorie, i risultati illustrano come le donne della popolazione generale siano prevalentemente caratterizzate da un attaccamento sicuro (F), ossia da un modello di organizzazione mentale dell’esperienza di attaccamento, funzionale e favorente un adeguato adattamento del soggetto al proprio ambiente, che dovrebbe derivare, come ipotizza la teoria, da relazioni primarie con figure di riferimento adeguate e sensibili nel corso dello sviluppo (Bowlby, 1969-1980). La distribuzione osservata, inoltre, non solo si pone in linea con gli assunti teorici, ma anche con i dati riportati da van Ijzendoorn e Bakermans-Kranenburg (1996) nel loro lavoro di meta-analisi sull’applicazione dell’AAI a diversi campioni di soggetti della popolazione generale, appartenenti a vari contesti culturali, spingendoci a considerare il presente gruppo di donne non tossicodipendenti come un buon confronto rispetto alla popolazione clinica considerata. Diversamente, nel campione clinico emergono proporzioni assai elevate di attaccamento insicuro, la cui presenza è riconducibile a diversi fattori, tra cui, l’esposizione di questi soggetti a contesti di crescita particolarmente disadattivi sperimentati prococemente. Come evidenziato anche dai dati socio-demografici descrittivi, infatti, il contesto affettivo-relazionale delle donne tossicodipendenti nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza è stato caratterizzato da situazioni di grave disagio presenti, soprattutto, all’interno delle famiglie di origine; secondo quanto ipotizzato dalla teoria, diversamente da situazioni di accudimento sensibile che costituiscono elementi di protezione per il soggetto e per la costruzione della sicurezza, ambienti di allevamento e di crescita insensibili, trascuranti o marcatamente maltrattanti possono costituirsi invece come fattori continuativi di rischio evolutivo la cui portata invalida proprio l’esperienza di base sicura (Bowlby, 1988; Cicchetti & Rizley, 1981; Rutter, 1989). In termini di ecologia dello sviluppo (Bronfenbrenner, 1977, 1979) è possibile parlare di sistemi genitore-bambino-ambiente disfunzionali che hanno condotto all’esperienza precoce di trascuratezza e cure non adeguate all’interno delle famiglie di origine di queste donne, la cui carenza fondamentale sembra quella della protezione fornita dalle figure di riferimento primarie, talvolta matrici del pericolo a cui esse sono state esposte. In particolare, le donne tossicodipendenti partecipanti alla ricerca sono caratterizzate da un attaccamento di tipo Coinvolto (E) con aspetti di passività, rabbia, e confusione che sembrano testimoniare proprio la loro difficoltà nell’integrazione a livello mentale dei contenuti dell’esperienza vissuta con le proprie figure di attaccamento. Specificamente, il correlato della confusione che attraversa le modalità narrative dei soggetti sembra espressione di una scarsa capacità di mentalizzazione anche a livello metacognitivo riconducibile, da un punto di vista clinico, al funzionamento dei soggetti tossicomani nei quali l’azione spesso sostituisce la riflessione ed il pensiero che divengono, come in questo caso, vaghi e incoerenti (Bergeret, 1982; Olievenstein, 1993). In relazione alle tre categorie, il modello Coinvolto (E) rispetto alle esperienze del passato riguarda il 61% dei soggetti, contro il 15% delle donne del gruppo appartenente alla popolazione generale. Questa categoria di attaccamento rivela di fatto un’incapacità del soggetto di muoversi oltre un senso di sé, il quale risulta coinvolto, appunto, o intrappolato dai ricordi di relazioni precoci o esperienze negative che nel momento attuale sembrano ancora attivi ed operanti a livello dell’organizzazione mentale (Main & Goldwyn, 1991). Secondo quanto descritto dagli autori, dal punto di vista del funzionamento mentale, infatti, i soggetti invischiati (E) denotano un afflusso di emotività irrompente, il quale difficilmente riesce ad essere arginato da strategie di tipo cognitivo (Crittenden, 1999, Main & Goldwyn, 1991). Tali soggetti possono avere modalità passive che denotano una mal definita esperienza d’infanzia (E1); oppure apparire ancora profondamente arrabbiati e in conflitto rispetto ad esperienze o a relazioni infantili (E2); o ancora, rivelare uno stato di paura, confusione e sopraffazione rispetto ad esperienze traumatiche del passato e rispetto alle esperienze di attaccamento (E3). Quest’ultima sotto-categoria è quella più francamente patologica ed è raramente usata in campioni della popolazione generale (Main & Goldwyn, 1985-1991): nessun soggetto, infatti, appartenente questo gruppo di donne, ha ricevuto tale categoria di classificazione, contro 5 delle donne tossicodipendenti. La prevalenza di questo modello di attaccamento insicuro si discosta da quanto osservato nei giovani tossicodipendenti uomini il cui modello prevalente è quello Distanziante (Ds) (Ammaniti et al., 1997; Fava Vizziello et al., 1997), delineando una sorta di specificità al femminile nella manifestazione dell’insicurezza in questo gruppo di soggetti. A fronte, infatti, di una rete fortemente povera e deteriorata sembra che la scelta maschile conduca ad un meccanismo di difesa maggiormente basato sull’esclusione e sulla coartazione mnestica e affettiva dell’esperienza, che la donna utilizza in misura minore a causa dell’invischiamento e della confusione. In altre parole, è come se il coinvolgimento emerso dai resoconti di queste donne si costituisse come una sorta di strategia fallimentare di non mentalizzazione dell’esperienza passata e delle sequele ancora presenti ad essa collegate, in termini sia di sviluppo del sé, sia di sviluppo del sintomo. In tal senso, i soggetti tossicodipendenti maschi sembrano attuare strategie maggiormente protettive di allontanamento, laddove per le donne l’autoprotezione é ancora più difficoltosa. Tali aspetti emergono in maniera ancora più evidente quando consideriamo quattro categorie di attaccamento, in cui la non risoluzione riguarda proprio esperienze traumatiche, piuttosto che lutti o perdite sperimentate nell’infanzia dai soggetti. La presenza consistente della categoria Non Risolto (U) interessa, infatti, episodi di maltrattamento visti o subiti all’interno del nucleo familiare che vengono riportati da un numero considerevole di soggetti (n = 16) e che sembrano costituire nuclei di notevole sofferenza e di disagio rispetto alla crescita. Tali episodi si connotano come atti e carenze che turbano gravemente il bambino, attentando alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, intellettuale e morale, attraverso comportamenti trascuranti e/o lesioni fisiche, psichiche o sessuali da parte delle figure di riferimento che, per definizione, dovrebbero garantire l’integrità fisica e psicologica del piccolo stesso, prendendosi cura di lui (Quarto colloquio criminologico del Consiglio d’Europa; 1978), costituendo una drammatica contraddizione dell’usuale cura, nutrimento ed amore che i genitori elargiscono ai propri bambini (Mrazek & Mrazek, 1985). Le esperienze abusanti, vissute ed esperite dal gruppo delle donne tossicodipendenti, si contraddistinguono non solo per gravità e drammaticità, ma soprattutto per la caratteristica di ripetitività nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza di tali soggetti che sembra averli resi incapaci di prevedere e di organizzare comportamenti e strategie difensive a riguardo. Laddove infatti il genitore diviene fonte di paura per il bambino, perdendo la funzione protettrice e di "base sicura" (Ainsworth, 1978), per il bambino diventa difficile costruirsi un quadro integrato di strategie cognitive ed emotive poiché egli non sa cosa e quando aspettarsi dal genitore nel momento dell’espressione della propria condizione di bisogno. Gli effetti di tali episodi sono ancora visibili nella vita attuale di queste donne, le quali risultano inefficaci nelle modalità cognitive di processamento dell’informazione proveniente dall’ambiente e dalle relazioni, rispondendo agli abusi con modalità al limite del disorientamento e della disorganizzazione. Potremmo ipotizzare che le imponenti differenze di incidenza e di prevalenza della politossicodipendenza grave nella popolazione generale dei tossicodipendenti, tra maschi e femmine, indichi anche una diversa patogenesi tra i due sessi: estrema ratio per la donna, quasi sempre colpita precocemente e ripetutamente nel corpo, con coinvolgimenti in forme di prostituzione e di ripetuti aborti volontari avvenuti nel più totale disprezzo di se stessa per procurarsi la sostanza. Il corpo disprezzato diventa il luogo del passaggio all’atto, mentre il corpo gravido o il figlio da poco partorito, che ritroviamo nella maggior parte delle nostre donne tossicodipendenti, il luogo utopico del riscatto. Non è comunque da escludere che parte di questi attaccamenti costituiscano l’effetto dei drammatici tentativi di elaborazione della propria dignità femminile da ritrovare e della propria genitorialità da ricercare a dispetto delle esperienze passate in gravidanza e nel periodo successivo alla nascita. A questo proposito, Walsh (1995) ipotizza una connessione ed una similitudine eziologica tra alcuni comportamenti tra cui la promiscuità sessuale, definita come licenza sessuale all’interno di un gruppo, ed in particolare l’abuso di droghe che vengono accomunati all’origine, in quanto in connessione con uno stile di attaccamento insicuro; entrambi questi comportamenti potrebbero costituire agiti la cui patogenesi è collegabile con una difesa dalla continuità negli attaccamenti e con la possibilità di distanziarsi dalle singole figure e dal pesante flusso esperienziale della vita quotidiana. E’ comunque importante sottolineare che queste considerazioni riguardano i partecipanti al nostro studio (e non possono sic et simpliciter essere estese a tutto il fenomeno tossicomanico femminile) che è costituito da donne con storie tanto difficili, che neppure di fronte ad una gravidanza hanno trovato aiuto nella famiglia di origine, né in quella del partner ed hanno avuto bisogno di particolari strutture residenziali di sostegno. Ulteriore conferma ai dati riportati, deriva dalla massiccia percentuale di soggetti ai quali è stata assegnata una categoria mista, implicante un Modello Operativo multiplo di attaccamento che sembra porsi come caratteristica prevalente dell’organizzazione mentale dei soggetti. Tale risultato, inoltre, sembra connesso concettualmente anche ai risultati emersi dalle distribuzioni rispetto a tre e a quattro categorie di attaccamento, costituendo una sorta di verifica del peso reciproco di questi due aspetti. In altre parole, è possibile pensare che esista una sorta di filo conduttore tra la molteplicità del Modello di attaccamento e l’insicurezza, come se entrambi questi aspetti appartenessero ad un più vasto ambito di disfunzionalità delle rappresentazioni di attaccamento, laddove l’impossibilità della sicurezza costituisce un impedimento anche ad una organizzazione alternativa. In sostanza, un pattern di attaccamento insicuro, ma intrinsecamente coerente ed integrato potrebbe ugualmente costituire un Modello, di fatto, adattivo e strategico rispetto alla gestione individuale delle risorse personali e delle richieste ambientali. In questa direzione, un contributo interessante proviene dai risultati emersi da una ricerca in ambito italiano (Simonelli, 1998), in cui si è riscontrata all’interno di un campione normativo di donne, una associazione statisticamente significativa tra l’assegnazione della categoria sicuro (F) e la presenza di un Modello unitario di attaccamento, quando considerata la dicotomia Modello Unitario vs Multiplo secondo le indicazioni di Crittenden (1999). La commistione di strategie di attaccamento che caratterizza le donne tossicodipendenti sembra emergere come una sorta di collasso dell’organizzazione, probabilmente un collasso dalle origini, nel senso che la struttura rappresentativa non ha mai potuto raggiungere una forma unitaria nel corso dello sviluppo costruendosi sulla incoerenza e sulla disorganizzazione dell’esperienza e, in particolare, dei modi alternati di valutazione della stessa. Un’altra chiave di lettura delle storie di vita e delle esperienze che hanno improntato il percorso di questi soggetti, potrebbe essere fornita dalla valutazione del peso che alcuni eventi particolarmente forti e traumatici possono rivestire relativamente all’instaurarsi del sintomo tossicomanico e della dipendenza. L’alternanza tra evitamento ed invischiamento rimanda, comunque, ad un meccanismo di non integrazione in cui la difficoltà ad elaborare congiuntamente i diversi aspetti dell’esperienza sembra condurre ad una scissione dei modi di rapportarsi alla realtà interna, come a quella esterna, a tal punto da rendere irrecuperabile l’unità finale. La confusione relativa, quindi, allo stato mentale dell’attaccamento richiama processi di cattiva integrazione, sia a livello affettivo che a livello cognitivo (Crittenden, 1999), attualmente operanti in queste donne. L’atto in sé della assunzione di sostanza (continuato in genere durante la gravidanza, talora al momento stesso del parto, non raramente anche durante i primi anni di vita del bambino, sporadicamente, nonostante la protezione della comunità), in relazione alla condizione di attaccamento insicuro, potrebbe forse essere considerato nella sua duplice funzione: da una parte il ricorso attivo alla sostanza sembra consentire a tali soggetti il raggiungimento di una momentanea e transitoria condizione di annullamento delle difficoltà, una vera e propria autoterapia di fronte ad una tensione insopportabile. Diversamente dal bambino che, in situazioni di disagio e di pericolo, torna alla "base sicura" per ripristinare quel sentimento interno di sicurezza che lo rende poi capace di esplorare il mondo, i soggetti tossicomani cercano nella sostanza un ausilio esterno in grado di esorcizzare momentaneamente le paure e i fantasmi della loro vita, ma sulla base dell'esclusione delle difficoltà ambientali tra cui le difficili condizioni familiari grazie ad una alterazione dello stato di coscienza. Più difficile, per noi, é concepire l’effetto psicotropo della sostanza come un’integrazione temporanea delle strategie mentali, attraverso l’illusione riparatoria nella ricomposizione di quel senso di unità personale perduto come sintetizzato da Mc Dougall (1988) "la droga avrebbe il compito di restituire al soggetto il sentimento di essere "reale", "vivo", valido colmando i vuoti dell’Io, i vuoti di senso, per quanto riguarda la propria identità ed il modo di pensare al mondo". Ci sembra che, almeno in queste donne, l'abuso di droghe che si ricolleghi in gran parte ad abusi fisici e psichici, subiti nella realtà nella relazione con le figure genitoriali, non dia pace a un ritrovamento del sentimento del proprio io, ma che perpetui pesanti vissuti masochistici, di degrado e di autosvalutazione. |
Puoi usare il link proposto sotto per predere contatto con la Redazione di "PERSONALITA' / DIPENDENZE" per qualunque informazione tu desiderassi ricevere e per eventuale collaborazione scientifica; lo stesso vale per la Redazione di POL.it che ospita nelle sue pagine questa edizione on line. |