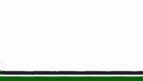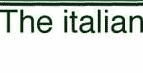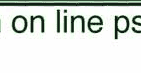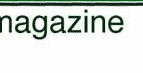|
|
|
|
|
| MARIO GALZIGNA Una riflessione epistemologica sulla diagnosi
Tutta la clinica psichiatrica, già a partire dalla sua nascita, nei primissimi anni dell’Ottocento, si organizza attorno a due matrici costitutive, cercando instancabilmente di collegarle e di armonizzarle: da un lato la percezione asilare del folle, istituzionalmente prodotta e giuridicamente definita, dall’altro lato l’iscrizione della condotta alienata (parole, deliri, posture, mimica, gesti, comportamenti) entro le maglie della concettualizzazione nosografica. [ 1 ] Tale concettualizzazione, ancorata ad una tradizione medica plurisecolare — esemplari, in questo senso, la mania e la malinconia di Philippe Pinel — conoscerà, nel tempo, continue modificazioni e importanti innovazioni, a partire dalla monomania di Esquirol fino alle nosografie attuali dei DSM e del più recente DSMIV. Le dinamiche della diagnosi, con le loro necessarie scansioni temporali ed evolutive, rappresentano uno dei terreni privilegiati di mediazione e di collegamento tra quelle che abbiamo definito le due matrici costitutive della clinica psichiatrica: e cioè tra una percezione diretta del folle ed una sua definizione nosografica; come dire: tra un approccio empirico reso possibile da precise norme istituzionali ed un approccio categoriale sempre e comunque supportato da un determinato assetto epistemologico (nonostante le dichiarate pretese, da parte di non pochi estensori dei DSM, di rappresentare un punto di vista "ateoretico" e meramente "descrittivo"). [ 2 ] Prima di sviluppare qualche riflessione epistemologica su questi due approcci — e sulla necessità di una loro corretta integrazione all’interno dell’atto diagnostico — vorrei prendere chiaramente le distanze da due posizioni estreme; due opposti estremismi, se così si può dire, che rischiano di compromettere gravemente la qualità della presa in carico e l’efficacia stessa delle terapie: da un lato un rigido diagnosticismo, che ci allontana dalla complessità personologica del paziente, dall’altro lato un cieco empirismo, incapace di cogliere con pienezza la specificità nosografica dei sintomi ed il loro orizzonte di senso: in altre parole, la loro inerenza ad una determinata sindrome ed al tempo stesso la loro appartenenza ad un particolare modo di essere nel mondo del paziente. Scrive molto correttamente Arnaldo Ballerini: "Sembra che ci si debba salvaguardare in psichiatria da due opposte posizioni: l’una che crede che lo stabilire diagnosi, con l’immanente rischio di catalogare anche le persone assieme al disturbo che le affligge (il tale è uno schizofrenico, l’altro un maniacale ecc.), sia il compito essenziale della prassi psichiatrica; l’altra posizione è invece quella che considera la diagnosi inutile e un inutile impedimento al contatto-comprensione e al prendersi cura del paziente in psichiatria, in quanto persona singolare, con irripetibile storia di vita, con singoli e specifici problemi che potrebbero svanire dietro ad una appagante definizione diagnostica". [ 3 ] Si tratta allora, fuori da qualsiasi rigidità dogmatica, di restituire validità clinica e spessore terapeutico all’atto diagnostico, concepito come dimensione dinamica — passibile di evoluzione e di mutamento — che migliora e progredisce in maniera direttamente proporzionale all’entità ed alla qualità della presa in carico del paziente e quindi, in ultima analisi, alla capacità, da parte del gruppo dei curanti, di conoscere e di comprendere, in maniera non superficiale, la sua storia ed il suo stile di vita. Prima di arrivare ad una definizione nosografica, occorre perciò dare molto spazio al momento empirico. Vogliamo far rientrare, in questa espressione sintetica, tutti i contatti diretti che il gruppo dei curanti riesce a stabilire con il paziente e con i suoi familiari. L’anamnesi storico-clinica sarà il primo importante risultato di questa varietà di approcci e di contatti: premessa insostituibile di ogni diagnosi corretta e non reificante, essa verrà costruita ed arricchita nel tempo proprio a partire dalla cooperazione continua tra operatori, medici e psicologi. L’anamnesi, in questa prospettiva, non sarà una semplice cronistoria dei sintomi e delle crisi. Sarà, molto più profondamente, un luogo di giunzione tra storia di vita e storia clinica. I sintomi, lo si sa, sono spesso "transnosografici"; sono cioè insufficienti, da soli, a individuare una patologia, soprattutto nella misura in cui vengono sottratti ad un orizzonte di senso: disincarnati, avulsi dalle caratteristiche del mondo interno, scissi dalla cultura familiare e sociale a cui il paziente appartiene. L’esperienza clinica presenta spesso casi di questo tipo e ci porta a diffidare di ogni etichettatura frettolosa e superficiale, spesso foriera di veri e propri errori diagnostici. L’esempio riportato da Ballerini nel suo saggio sulla diagnosi ci sembra molto significativo: il delirio persecutorio di una paziente — trattata con neurolettici a seguito di una diagnosi di psicosi paranoide — viene più attentamente indagato ed "ascoltato" dal gruppo dei curanti. "Nell’ascolto dell’angoscia persecutoria della paziente e nelle successive elaborazioni nel gruppo degli operatori ci si rese conto che in realtà la paziente viveva una situazione ‘terrifica’, allusivamente centrata su una immagine di sé come ‘strega’, come metafora di portatrice del ‘male’, e quindi della colpa. Un trattamento con antidepressivi triciclici portò ad una completa risoluzione della sindrome delirante". [ 4 ] Non mi sembra inutile citare un ulteriore esempio, tratto dall’esperienza clinica del DSM di Rovigo. M.G., una paziente trentaseienne, presenta un evidente disturbo ossessivo-compulsivo: seguendo rituali precisi e costanti, si lava molto spesso mani e braccia con varechina. Lava frequentemente anche il cane. Costringe il fidanzato a lavare e a disinfettare abiti e macchina, evidenziando una classica rupofobia (riferita al pericolo dell’AIDS). Il gruppo dei curanti, con molta cautela e senza giungere a conclusioni diagnostiche definitive, tende ad interpretare questi sintomi come manifestazioni di una grave nevrosi ossessivo-compulsiva. [ 5 ] L’osservazione prolungata della paziente e l’arricchimento dell’anamnesi getteranno nuova luce su questo caso molto difficile, orientando sempre di più i terapeuti verso una diagnosi di psicosi. I sintomi DOC, nel caso di M.G., sembrano assolvere ad una funzione ben nota nella letteratura clinica: proteggono la paziente da una disintegrazione psicotica, svolgendo così una funzione "utile", come afferma Gabbard, "in termini di omeostasi psicologica". [ 6 ] Anche in questo caso vale la constatazione di Gabbard: i sintomi possono accompagnare qualunque livello di personalità sottostante o di organizzazione dell’Io. Per comprendere la loro funzione all’interno della struttura intrapsichica globale del paziente, è dunque necessaria un’anamnesi molto attenta ed una conseguente valutazione di carattere psicodinamico, a partire dalla quale la definizione nosografica potrà essere più credibile e più puntuale. Vediamo meglio. La madre di M.G., casalinga tradita dal marito, era stata messa a fuoco, in un primo momento, come madre depressa. Indagini più attente — rese possibili anche da una maggior circolazione dell’informazione tra i curanti — evidenziano una realtà diversa e più complessa. Questa casalinga tradita dal marito, certamente angosciata da vissuti depressivi di scacco e di rinuncia, è in realtà, per la figlia, una figura persecutoria: è una madre sessuofobica e pesantemente intrusiva. Rappresenta quindi, per M.G., il principale veicolo di un Super-io severo, persecutorio, non integrabile. Un Super-io che non produce rimozione delle pulsioni, con conseguente sintomo (è lo schema della nevrosi), ma rigetto, werverfung, delezione delle pulsioni. I sintomi DOC non sembrano quindi sintomi nevrotici (in questo caso sintomi di una nevrosi ossessivo-compulsiva), ma manifestazioni morbose che caratterizzano (non la coprono, si badi bene: la caratterizzano!) una situazione di Io dissociato e frammentato. Un dato sottovalutato precedentemente acquista ora nuova luce: M.G. avrebbe sofferto, in passato, di qualche allucinazione. Nel suo recente ricovero in SPDC ha manifestato la presenza di allucinazioni uditive. Il quadro clinico, caratterizzato da vari tentativi di suicidio e da un tentato abuso sessuale da parte del padre (quando la paziente aveva 7 anni), si è ulteriormente complicato, da qualche tempo, per la presenza di una condotta bulimica che ha pesantemente alterato la fisicità della paziente. Come ben si vede da questo esempio clinico, la diagnosi non è una classificazione reificante e definitoria, formulata ab imis. E’ in realtà un’attività dinamica complessa: attraverso la cooperazione tra i curanti, essa progredisce e si sviluppa nel tempo, avvalendosi della maggior capacità — sviluppata dall’intera équipe psichiatrica — di conoscere e di comprendere in maniera non superficiale il mondo interno della paziente ed il contesto delle sue relazioni familiari e sociali. In questo classico caso di confine, come si usa dire (un caso di confine tra disturbo DOC e psicosi), la diagnosi categoriale lascia il posto alla diagnosi dimensionale, più complessa ma certamente più adeguata ad inscrivere i sintomi — soprattutto i sintomi transnosografici — entro un orizzonte di senso. "Un approccio di tipo dimensionale riduce il rischio di stigmatizzazione connesso all’uso di etichette diagnostiche e facilita la classificazione di casi al confine tra differenti categorie, dei casi difficili e della comorbidità". [ 7 ] La diagnosi dimensionale, concepita come strumento adatto a superare i limiti della diagnosi categoriale e la sua incapacità di comprendere i casi più complessi, è possibile solo a partire da due condizioni preliminari: una buona coesione tra i singoli membri dell’équipe terapeutica ed una capacità di collegare strettamente i sintomi alla storia del paziente: alla sua storia di vita, alla sua cultura di appartenenza, alle sue relazioni familiari e sociali. Utilizzare, a fini classificatori, le dimensioni al posto delle categorie significa — non lo si dimentichi — distribuire le malattie, secondo variazioni quantitative, all’interno di un continuum, come ha affermato correttamente Paolo Migone, "che va fino alla normalità". Un continuum di gradazioni, che va dalla salute alla malattia, diventa uno strumento euristico di rara efficacia per comprendere le genesi lontana — familiare e sociale — di determinate patologie: il loro radicamento in contesti apparentemente sani che però contengono, in nuce, spesso allo stato di condizione premorbosa, i germi della futura malattia. [ 8 ] N O T E
|
POL.it è organizzata per rubriche e sezioni affidate a Redattori volontari che coordinano le varie parti della Rivista. Anche tu puoi divenare collaboratore fisso o saltuario della testata, scrivi utlizzando il link proposto sottto, dando la tua disponibilità in termini di tempo e di interessi, verrai immediatamente contattato. Come tante realtà sulla rete POL.it si basa sul lavoro cooperativo ed è sempre alla ricerca di nuovi collaboratori, certi come siamo che solo un allargamento della cerchia dei suoi redattori può garantire alla Rivista la sua continua crescita in termini di contenuti e qualità. ti aspettiamo..... |


© POL.it 2002 All Rights Reserved