|


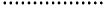
Lo spazio di recensioni cinematografiche di POL.it, inaugurato da poco, è aperto a suggerimenti e contributi.
L'esperienza di derealizzazione, l'inflazione dell'immaginario, il nulla, la fantasia di sparizione.1 Un percorso psicopatologico dal film "The Truman Show" (Peter Weir, USA, 1998) a "Film" (Samuel Beckett, Irl, 1960) E' troppo ricco nella messa in scena, troppo perfetto nella fotografia e nel montaggio, Jim Carrey ha troppo la faccia di gomma, è, insomma, troppo hollywoodiano, "The Truman Show", perché lo si possa amare. Tuttavia il film merita una segnalazione, per il tema dello script e per alcune situazioni palesemente leggibili in chiave psicopatologica. Truman, un tipico american boy, all'età di trent'anni si accorge che tutta la sua vita è una gigantesca soap opera prodotta da un grande network televisivo, realizzata mediante 5000 telecamere posizionate ognidove, centinaia di attori e comparse che mostrano i prodotti di innumerevoli sponsors, e diretta da una navicella spaziale da un regista-onnipotente, di nome Christof. L'esperienza chiave di Truman non è dissimile da quella di frequente riscontro nella clinica delle psicosi: sentimenti di estraneità ambientale e derealizzazione, interpretazioni ed intuizioni deliranti di alcuni eventi ambigui, nascita dei convincimenti circa la falsa identità di chi circonda il paziente, inclusi i parenti stretti, di essere spiati e controllati da telecamere poste nei muri e tra le siepi del giardino e così via: esperienze terrificanti ma sovente effimere quelle riferite dai pazienti, che nel film sono trasfigurate in una storia fantascientifica splendidamente congegnata fin nei particolari contenutistici e formali. La storia di Truman si apre anche ad una interpretazione simbolica e metaforica indicando nello strapotere della televisione su chi la fa e chi ne fruisce l'agente di un controllo sociale un tempo operato dalle religioni, ma soprattutto evidenziando il carattere trascendentale della struttura del rapporto con questo media: Truman è stato creato, diretto e controllato dal regista Christof, ed alla fine dovrà liberamente scegliere se restargli fedele. In questo sfondo metaforico trascendentale ritroviamo temi cari a Peter Weir, soprattutto nel suo capolavoro australiano "Picnic a Hanging Rock" (1975); là il complesso sintomatico derealizzazione -panico-depersonalizzazione - metamorfosi veniva analizzato in un ben preciso contesto storico, simbolico e mitologico2, qui viene mostrato lo sviluppo delirante delle esperienze di depersonalizzazione in una dimensione apparentemente tutta quotidiana ma, in effetti non meno simbolica e metaforica. La verosimiglianza psicopatologica di "The Truman Show" non si ferma al piano descrittivo, ma affonda anche in alcuni spunti d'interesse psicodinamico, in particolare nello strutturarsi intorno ad un vero e proprio romanzo familiare: il leit motiv della soap opera è infatti la morte per annegamento del padre di Truman che, da piccolo, vi aveva assistito e che rammemora con chiare sfumature di colpa; questa finzione, fatta credere a Truman da tutti, madre compresa, viene sfatata dallo stesso padre che ogni tanto riappare nei panni di un barbone, al punto da far decidere Christof ad utilizzare melodrammaticamente l'incontro e l'abbraccio definitivo tra il figlio ed il padre "risuscitato". "The Truman Show" conferma la attuale tendenza del cinema a riflettere su se stesso non più col classico espediente del film nel film o della recita nel film, ma nel mostrare storie i cui protagonisti non sono personaggi reali ma virtuali: immagini televisive su viedeotapes, in quello che è forse il prototipo di questo genere cinematografico, e cioè "Videodrome" (1982) di David Cronenberg3, l'immagine di un personaggio del cinema dei telefoni bianchi in "La rosa purpurea del Cairo" di Woody Allen (1985), immagini-ricordi femminili in videotapes in "Sesso, bugie e videotapes" di Soderbergh (1989), un cartone animato, in "Volere volare" di Maurizio Nichetti (1991), il personaggio di un videogioco in "Nirvana" di Gabriele Salvatores (1997), il personaggio in una vita virtuale garantita da una compagnia assicurativa nel recente film spagnolo "Apri gli occhi" (1998). Tutti i protagonisti di questi film sono, con vari accenti emotivi, persecutoriamente ingabbiati in meccanismi che non consentono loro una discriminazione tra reale e virtuale, rendendoli inermi immagini percepibili da tutti, impotenti e smarrite, desiderose soltanto di ridivenire normali esseri in carne ed ossa. Se da un lato questi film raddoppiano iperrealisticamente il carattere di finzione dell'immagine cinematografica e del voyeurismo che soddisfa, dall'altra mettono in scena una condizione sociale diffusa nella quale le persone si vivono sempre di più come apparenze e personaggi, in un'inflazione dell'immaginario che nasce da una percezione della realtà priva di spessore emotivo: in assenza di un nucleo di identità forte, di "immagini personali interiorizzate" saldamente amalgamate con la matrice affettivo-pulsionale, nessuno può sapere qual'è la propria identità e finisce per identificarla nelle immagini che gli vengono socialmente imposte e/o proposte. La vita è sempre più un sogno, di cui noi siamo i personaggi, ma solo a volte anche i sognatori. Le vite riprese in diretta 24 su 24 su Internet (e l'interesse che hanno suscitato) sembrano al momento l'esempio più radicale di questa tendenza antropologica. Alla fine del film Truman potrà ribellarsi al suo destino preconfezionato e pubblico; ma non si sa che cosa troverà al di là della porta buia che dovrà attraversare: come le ragazze-ninfe scomparse su Hanging Rock, forse il nulla. E' in questo affascinante finale che "The Truman Show" si sottrae definitivamente alle letture sociologiche per sollevare la questione ontologica dell'esse est percipi, genialmente intuita come essenziale per il cinema nell'unico film ideato da Samuel Beckett e, si ricorderà, interpretato dall'uomo-marionetta/immagine per eccellenza, Buster Keaton: "Film", del 1960, "il più grande film irlandese", come lo ricorda Deleuze4. Attore quasi unico, Buster Keaton, monocolo (con tanto di benda nera ad un occhio), corre accanto ad un muro per non essere visto, e si rinserra in una stanza dove provvede con sistematicità a eliminare, coprire, velare, ogni finestra, ogni pertugio, occhio, umano o animale, reale o in effige che sia, in una sorta di blindatura paranoicale. Quando l'accurata operazione, che è tutto il film, e nella quale non mancano gags grottesche degne di Beckett non meno che di Keaton (ad esempio il gatto che si ostina a rientrare dalla porta dalla quale viene fatto uscire), si compie, ecco la scoperta dell'orrore: l'unico occhio che non è stato spento è quello, narrante, della macchina da presa, che finora aveva seguito sornionamente di spalle l'ignaro protagonista: "Finchè la percezione resta dietro il protagonista non è pericolosa, perché resta inconscia"4 , quando si rivela nel campo ottico dell'ignaro attore mostra il suo carattere insopprimibilmente legato alla coscienza di sé. Coscienza di sé, coscienza dell'Io, di cui la derealizzazione è tradizionalmente considerata un disturbo, è auto-osservazione. Il circolo sembra chiudersi: se non si è percepiti non si è, se si è percepiti si è, meglio essere un personaggio che niente. Senza di te, senza il tuo sguardo, senza essere qualcosa per te, io sono nulla, dice l'amante all'amato, ma anche il paziente al terapeuta. Ma se ci si rifiuta di essere personaggi di noi stessi, allora nasce la voglia di sparire di Keaton e di Truman, e di tutti gli altri sopra ricordati eroi che si accorgono di essere trasformati in immagini, accomunati dal tropismo mortale che nasce dall'orrore di apparire. Siamo, credo, alla questione fondamentale sul destino della follia, che talora anche il cinema d'Autore riesce a riproporre: laddove il paziente incarna il desiderio radicale di non percepirsi, cioè di non essere più percepito, è abolita la condizione necessaria per qualsivoglia terapia. Riferimenti bibliografici 1 La nozione di fantasia di sparizione, come è noto, è di M.Fagioli. Cfr. Fagioli M (1972), Istinto di morte e conoscenza, Nuove Edizioni Romane, Roma 1996 VIII 2 Maggini C., Dalle Luche R.: "Pic nic ad Hanging Rock" e líevidenza enigmatica del mito. In: M.Betti, E. Marchi, G.Zanda, Esperienze Psichiatriche in Video, atti del relativo convegno, Bagni di Lucca 12-13/4/1991, Ed. Maxmaur ñPsichiatria e Territorio.3 Dalle Luche R., Barontini A.: Transfusioni. Saggio di psicopatologia dal cinema di David Cronenberg. Mauro Baroni Editore, Viareggio, 1997.4 Deleuze G.: Il più grande film irlandese ("Film" di Samuel Beckett). In: Critica e clinica, Raffaello Cortina, Milano, 1996. Riccardo Dalle Luche    
|
